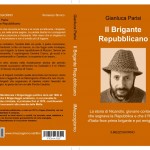In un romanzo la storia dell’unità d’Italia vista da un
contadino dell’Agro Caleno
Caleno24ore, 18 aprile 2012
Il Brigante repubblicano è l'ultima fatica editoriale di
Gianluca Parisi.
Tutti conoscono, per sentito dire o per averla studiata a
scuola,
Ma come mai il protagonista dell’unità nazionale, uno dei
padri della nazione italiana veniva impallinato da
quello che doveva essere l’esercito del nuovo Regno d’Italia? Come
Il protagonista Nicandro, è un contadino che aspetta
l’arrivo al suo paese di Garibaldi che marciava verso Teano per incontrare il
re Vittorio Emanuele II. Sperava che gli venisse
assegnata la terra da coltivare, ma ben presto si rende conto che la sua era
solo un’illusione. Scacciato dal barone del posto, ripara sui monti dove si imbatte in una banda di briganti. Vive la storia di
personaggi dal calibro di Carmine Crocco e Luigi Alonzi detto “Chiavone”.
Il protagonista del romanzo è
chiaramente inventato come pure i nomi della maggior parte dei briganti della
sua banda; ma sono veri tutti gli episodi avvenuti in quel periodo: dal
bombardamento di Gaeta all’eccidio di Pontelandolfo e
Casalduni; alle fucilazioni di massa a Scurcola, a quelle sommarie ai singoli sospettati di
brigantaggio.
A scuola lo studio della storia dell’Unità d’Italia si ferma all’incontro di
Teano; gli anni immediatamente successivi sono trattati sommariamente oppure
archiviati superficialmente alla voce Brigantaggio.
Gli storici in passato hanno spesso fatto di tutta l’erba un fascio: di contadini, di delinquenti, di camorristi
e mafiosi. Poi ci si è ritrovati ad affrontare disamine e disamine
sulla Questione Meridionale mai più risolta. Ma cosa
ha dato origine a tale “Questione”? Cosa indusse i
contadini a posare le zappe, imbracciare i fucili e ad unirsi a briganti e
delinquenti comuni? Il Brigantaggio post unitario più che una conseguenza di
una colonizzazione nordista a danno del Mezzogiorno d’Italia, sembrerebbe
originato da un capriccio delle monarchie Sabauda e Borbonica, imparentate tra di loro, che strumentalizzarono e politicizzarono il
fenomeno per proprio tornaconto.
A farne le spese, come spesso accade, furono i più poveri,
i contadini e chi, come Nicandro, aveva creduto
nell’Italia Repubblicana e in Garibaldi. I contadini già con i Borboni vivevano in una condizione di miseria, i Savoia li resero ancora più miseri privandoli
dell’utilizzo delle terre demaniali, che finirono gradualmente nelle mani di
ricchi signorotti e baroni. Furono privati di poter raccogliere la legna nei
boschi, di poter pascolare i propri armenti, cose che prima facevano in tutta
tranquillità. E fu guerra civile, con una repressione
durissima durata per ben 10 lunghi anni che non risparmiò neanche donne, vecchi
e bambini.
Di questi tempi tristi nessun erede delle monarchie sabauta e borbonica ha chiesto scusa alle popolazioni del
Mezzogiorno d’Italia. Di quei tempi tristi restano solo racconti di gesta
orribili e scellerate. Ma forse c’è anche qualche storia benevola: ancora oggi
in qualche borgo di Terra di Lavoro nel Basso Lazio si tramanda da nonna a nipote
la leggenda della fanciulla Trusiana figlia di
brigante.